Lo scopo centrale di ogni arte è la liberazione del potenziale umano, per far progredire ed espandere le possibilità di esperienza, realizzazione e significato. Negli ultimi due secoli la fotografia è diventata una delle principali forme di comunicazione umana. Soprattutto negli ultimi decenni, è arrivata ad affiancare la comunicazione verbale come mezzo fondamentale per condividere non solo le nostre visioni, ma anche i nostri pensieri e le nostre esperienze. La fotografia permea le nostre vite nella cultura moderna. Quali sono le frontiere che la fotografia deve ancora esplorare? Una possibilità potrebbe essere rappresentata da nuovi tipi di strutture di comunicazione basate su un ordine puramente visivo, piuttosto che su una correlazione diretta con le narrazioni verbali.

L’affermazione “Ogni immagine racconta una storia” è falsa. Le immagini non raccontano storie. Le nostre menti inventano storie sulle immagini quando le guardiamo. Le fotografie non sono generalmente ambigue come le macchie d’inchiostro, ma ciò che accade quando le guardiamo non è dissimile.
L’inferenza di una storia da una fotografia è più fondamentale della storia stessa. Da questo punto di vista, si alleggerisce la morsa delle presunzioni politiche letterali, si svelano le opportunità di considerazioni basate sulle connessioni e si possono dedurre conclusioni etiche pragmatiche dalle connessioni.
La fotografia è stata a lungo liberata da ogni misura affidabile di oggettività. Ciò ha offerto ai fotografi una libertà creativa selvaggia e la possibilità di un nuovo standard di critica, basato sull’intento piuttosto che sul contenuto, sull’empatia piuttosto che sull’esclusione e sulla curiosità liberata piuttosto che su un concetto scontato.
Per certi versi, può sembrare che la risposta a questa liberazione sia stata un ripiegamento su una narrazione di attualità o su stretti collari concettuali. In genere, questa è più una risposta al protocollo istituzionale e alle pressioni del mercato per stabilire un marchio che alla curiosità creativa. Rebecca Solnit scrive: “La linea retta della narrazione convenzionale è troppo spesso un’autostrada sopraelevata che non permette incontri imprevisti o deviazioni necessarie. Non è il modo in cui viaggiano i nostri pensieri, né ci permette di mappare il mondo intero piuttosto che una traiettoria snella attraverso di esso”. O, più sinteticamente, “Le stelle che ci vengono date. Le costellazioni che creiamo”.

La fotografia si colloca all’intersezione tra mente soggettiva e meccanismo oggettivo. L’immobilità dell’immagine fotografica rende possibile l’analisi dell’interazione tra intento personale e riproduzione tecnologica. Un fotografo percepisce qualcosa di intrigante, dirige la macchina fotografica verso di esso, fa scattare l’otturatore e il meccanismo ritrae ogni capello, ramoscello, granello, macchia, ombra, scintillio, angolo e inflessione. L’immagine risultante può poi essere decodificata per rivelare la fonte dell’intrigo iniziale e/o informazioni non intenzionali. La tecnologia ottica registra più di quanto l’attenzione comune possa permettere, e quindi permette una considerazione attenta. L’empirismo meccanico è diretto dall’opinione, e poi riforma l’opinione con informazioni particolari. Le immagini sono portatili e relativamente permanenti, il che significa che le loro informazioni possono essere inserite in contesti altrimenti impossibili in qualsiasi momento. Possiamo vedere un incendio nel comfort di un salotto in un giorno di pioggia. Un senatore è stato accostato a un terrorista. Un corpo nudo si rivela nel retrobottega di un negozio. Una giornata in spiaggia può essere ricordata nel cuore dell’inverno. L’irresistibile persuasione delle immagini sta nel modo in cui la mente seleziona, interpreta e riempie i vuoti. La mente, o più precisamente la coscienza, è l’effetto fondamentale.
Julian Jaynes offre un’utile definizione di coscienza nel suo libro “The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind“. Inizia spiegando cosa non è, a cosa non serve. Con semplici osservazioni, analogie ed esempi, chiarisce come sia sorprendente che ben poco della nostra esistenza entri nella soglia della nostra consapevolezza. In effetti, così poco dell’esperienza emerge nella coscienza che è facile concludere che non è affatto necessario. Non solo i formicai, gli alveari e i banchi di pesci sono possibili senza di essa, ma anche Babilonia avrebbe potuto esserlo.
Poi arriva al nocciolo della questione: “La mente cosciente soggettiva è un analogo di quello che viene chiamato il mondo reale. È costituita da un vocabolario o campo lessicale i cui termini sono tutti metafore o analoghi del comportamento nel mondo fisico. La sua realtà è dello stesso ordine della matematica. Ci permette di abbreviare i processi comportamentali e di arrivare a decisioni più adeguate. Come la matematica, è un operatore piuttosto che una cosa o un deposito. Ed è intimamente legata alla volizione e alla decisione”.

Egli usa il termine analogico come se si applicasse a un tipo speciale di modello, come una mappa. Una mappa “non è un modello in senso scientifico, non è un modello ipotetico come l’atomo di Bohr per spiegare qualcosa di sconosciuto. È invece costruita con qualcosa di ben noto, se non del tutto conosciuto. A ogni regione di un distretto di terra viene assegnata una regione corrispondente sulla mappa, anche se i materiali della terra e della mappa sono assolutamente diversi e gran parte delle caratteristiche della terra devono essere tralasciate. La relazione tra una mappa analogica e il suo territorio è una metafora. Se indico una località su una mappa e dico: “Lì c’è il Monte Bianco e da Chamonix possiamo raggiungere la parete est in questo modo”, questo è in realtà un modo sintetico per dire: “Le relazioni tra il punto etichettato come ‘Monte Bianco’ e gli altri punti sono simili al vero Monte Bianco e alle regioni vicine”.
Infine, Jaynes definisce la natura funzionante della coscienza in una sorta di scossa dello specchio di carnevale in cui la coscienza si azzera su se stessa: “Una proprietà cardinale di un analogico è che il modo in cui viene generato non è il modo in cui viene utilizzato – ovviamente. Un creatore di mappe e un utente di mappe stanno facendo due cose diverse”. La coscienza funziona come chi usa e crea una mappa, scansionando i dati della sensazione e della memoria per scegliere una direzione narrativa analogica di azione. “È attraverso la struttura generata della coscienza che comprendiamo il mondo”.
È interessante notare che Julian Jaynes ha pubblicato “The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind” nello stesso anno in cui il Museum of Modern Art ha pubblicato “William Eggleston’s Guide” con il saggio introduttivo di John Szarkowski. Szarkowski conclude che le perfette fotografie di Eggleston sono “surrogati irriducibili dell’esperienza che pretendono di registrare, analoghi visivi della qualità di una vita, collettivamente un paradigma di una visione privata, una visione che si sarebbe pensata ineffabile, qui descritta con chiarezza, pienezza ed eleganza”.

Il rapporto tra le parole di Szarkowski che descrivono il lavoro di Eggleston e quelle di Jaynes che definiscono le funzioni della coscienza è simile al rapporto tra una mappa e una guida. Szarkowski cita Robert Adams: “La forma che il fotografo registra, sebbene scoperta in una frazione di secondo di fatto, implica un ordine al di là di se stessa, un paesaggio in cui tutti i frammenti, per quanto imperfetti, si inseriscono perfettamente”. Una fotografia è in effetti una sorta di mappa in sé e per sé. La cartografia moderna si basa sulle fotografie. Entrambe portano con sé implicazioni di localizzazione, viaggio e narrazione.
La tendenza prevalente nella fotografia è quella di raccontare una storia e, nel caso di fotografie destinate alla vendita, di farlo con uno stile autografico e riconoscibile. Il lavoro di Eggleston trascende la mera narrazione di stile senza abbandonarla. Mentre le sue immagini descrivono il suo mondo, suggeriscono anche una descrizione della descrizione, una coscienza della coscienza.
Tuttavia, la narrazione in fotografia è una sorta di vincolo, una formula che tiene accuratamente rinchiuse le incertezze e le routine della consapevolezza. Alcuni fotografi hanno intaccato questa tenace oggettività narrativa con vari gradi di successo. Szarkowski ha scritto che “le migliori idee di Edward Weston ci vengono date come pura sensazione”. Aaron Siskind ha spinto il suo lavoro verso un formalismo estremo che si rivolgeva a quello che lui chiamava “il vasto regno comune dei ricordi che sono scesi al di sotto del livello di controllo cosciente”. Eggleston ha pubblicato “The Democratic Forest” e “Los Alamos”, che resistono entrambi ai contorni dell’attualità. Dopo la pubblicazione di “The Americans”, Robert Frank ha iniziato a realizzare immagini che sfidavano i precetti della narrazione. Più di recente Wolfgang Tillmans si è concentrato in particolare sulla rottura del ruolo descrittivo della fotografia. La precarietà della direzione suggerita da questo tipo di lavoro è che può diventare rapidamente un pastiche pittorico arbitrario, solipsistico e pittorialista della pittura, o un discorso arido nel formalismo. Intelligenza, disciplina e forza di volontà possono mitigare il rischio. Ma una volta compromessa la squisita capacità di resa della fotografia, la potenza della sua capacità di implicare un ordine al di là di se stessa è generalmente ridotta. Le fotografie di Andreas Gursky adottano l’approccio opposto, offrendo banchetti di tableau epici e mozzafiato, costruiti attorno a grandi temi di globalizzazione e analisi postmoderna. L’uso della tecnologia digitale per manipolare la scala e il contenuto solleva questioni di veridicità, provocando un’interessante riflessione sulla credulità. Ancora una volta, la prospettiva della mera parodia si presenta una volta che la battuta è stata divulgata. Le manipolazioni evidenti dei fatti richiedono inevitabilmente una forte sospensione dell’incredulità.

Negli ultimi decenni alcuni fotografi e critici hanno iniziato a parlare dell’esistenza di una narrazione al di fuori dell’immagine. Scrivendo del lavoro di Roe Ethridge, Martha Schwendener ha scritto che “gli spettatori creano, nella loro mente, una narrazione completamente disegnata da informazioni frammentarie”. Ethridge esplora il territorio che gli è stato aperto dalla sua esperienza di fotografo di riviste editoriali, riecheggiando i percorsi di fotografi come Juergen Teller o Wolfgang Tillmans, e scrollandosi di dosso i vincoli tipologici della “Scuola di Dusseldorff” ispirata da Bernd e Hiller Becher. Sebbene le sue immagini inizino con un incarico editoriale tematico – sia che provengano da un editore o che siano state create da lui stesso – il modo in cui successivamente le seleziona e le giustappone per la pubblicazione o l’esposizione si allontana dai tipici schemi di associazione per offrire agli spettatori delle sue immagini lo spazio per diventare consapevoli del proprio ruolo nella comprensione dell’esperienza. La natura altamente suggestiva e irrisolta di questo tipo di editing può richiamare l’attenzione sull’immaginazione dello spettatore tanto quanto l’intenzione del fotografo.
Joann Verburg è riuscita a far riflettere sul modo in cui le storie vengono create nel contesto della sua stessa storia. Realizzando una serie rigorosa di fotografie intimamente domestiche del marito e della vita di casa, che utilizzano le capacità di spostamento della prospettiva e della messa a fuoco del banco ottico 8″ X 10″, gli elementi all’interno di ogni immagine si rivelano avere una potenza simbolica fino ad allora insospettata. In particolare, l’artista include spesso nelle sue fotografie materiale di lettura stampato – libri, riviste e giornali – che indica mondi esterni alla cornice all’interno dell’inquadratura. Queste torsioni, ancora una volta, richiamano la consapevolezza delle attività di eco della mente.
Tutto ciò suggerisce che è possibile e interessante descrivere più intenzionalmente e minuziosamente la descrizione con la fotografia. Scrivendo del lavoro di Lee Friedlander, Peter Galassi parla della “fecondità circolare… in cui il descritto e la descrizione – l’inesauribile quiddità del mondo e i modi in cui la fotografia può esplorarlo – si susseguono come l’uovo e la gallina”. Forse il potere raffigurativo della fotografia può essere applicato per sconvolgere la semplice narrazione, senza alcun compromesso con i fatti registrati dalla tecnologia, e portare piena attenzione al “processo che inventa il nostro mondo analogico”.

Si può affermare che si presta troppa poca attenzione all’atto di inventare la narrazione. Nel gergo giornalistico corrente si trovano frasi come “unire i puntini”, “intelligenza selezionata” e “la teoria del cambiamento climatico causato dall’uomo”. La grossolana manipolazione dell’opinione compiuta dai collegamenti impliciti di un senatore accostato a un terrorista è tipica dell’invenzione narrativa concorrente. Solo esaminando oggettivamente la generazione di analogie significative, la lucidità della consapevolezza può distinguere l’intenzione.
La fotografia ha sempre avuto un rapporto piuttosto teso con la verità oggettiva. Oggi è più vero che mai. Una ricerca su Google di Photoshop produce 150 milioni di risultati, mentre una ricerca di Coca Cola ne produce circa sei milioni. La potenza e la proliferazione della tecnologia di manipolazione delle immagini obbliga i fotografi a stabilire e rispettare rigorosamente le regole e l’etica del loro gioco. I fotoreporter sono stati banditi per essere stati sorpresi ad alterare il loro lavoro. L’unico mezzo che il pubblico ha per determinare la veridicità di un’immagine è la consapevolezza del suo intento. Accettiamo i rendering pesantemente ritoccati di celebrità e modelle, ma non quelli di bambini affamati o di manifestazioni violente. A volte lo scetticismo sfocia nella paranoia, come nel caso del film di Zapruder, delle missioni Apollo, dell’11 settembre e delle accademie decostruttiviste. Gli scettici greci originari affermavano: “Nulla è vero, nemmeno questo”. La fotografia impone la questione dell’intenzione.
Di quale intenzione ci si può fidare? Qualsiasi ambizione di persuasione tende a confondere le acque abbastanza rapidamente. Se la fotografia attivista di denuncia fosse in grado di salvare il mondo – o di dominarlo – lo avrebbe fatto molto tempo fa. Affrontare questa consapevolezza può essere liberatorio. Se ciò che i fotografi fanno non può salvare direttamente niente o nessuno, il peso della responsabilità viene spostato. Una volta che il fumo si è diradato, i fotografi possono dedicarsi al semplice e infinito compito di descrivere. Questo è l’obiettivo e l’aspirazione a cui si può credere. Emmet Gowin descrive il compito come “… cercare qualcosa che metta i nostri sentimenti indicibili in una forma discreta, in modo che noi stessi possiamo allontanarci e studiare ciò che abbiamo fatto. E, in un certo senso, riconoscere i nostri sentimenti come un oggetto”.
Robert Adams ha dichiarato: “Non si può parlare di vita senza parlare di politica. Bisogna avere entrambe le cose. Se sei solo una persona politica, ti brucerai. Se, come artista, ti concentri solo su te stesso, finirai per essere irrilevante”. Questa verità può essere interpretata in modo restrittivo, per implicare che si devono illustrare le questioni politiche alla lettera, oppure, in modo più libero, partendo dalla consapevolezza che ogni volta che si parla di -descrivere- la vita, ne conseguono implicazioni etiche e politiche. Vita e politica, come tutte le cose, sono inestricabilmente legate. Non è necessario forzare l’una per affrontare l’altra. In un certo senso, una rappresentazione letterale delle preoccupazioni politiche nasconde le connessioni che rafforzano pratiche etiche chiare e durature. In ogni caso, come sosteneva George Orwell e come dimostrano le inesistenti armi di distruzione di massa, le dichiarazioni politiche persuasive si basano più sullo stile che sulla sostanza.
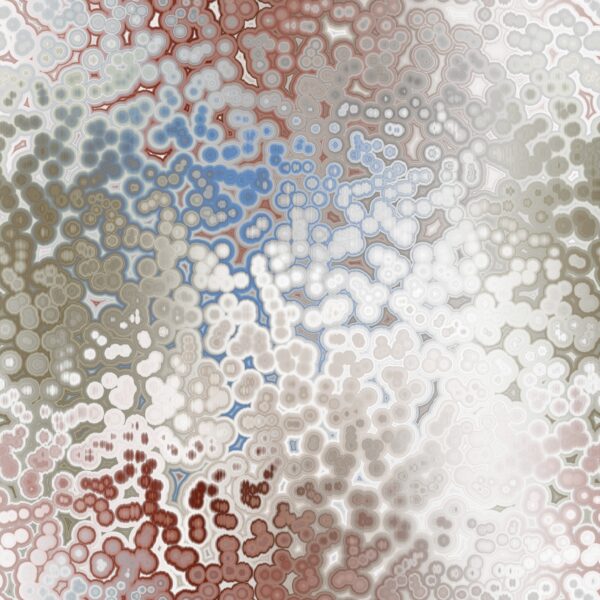
Ogni fotografo sa bene come i meccanismi oggettivi della tecnologia fotografica possano minare i suoi obiettivi. Una foto dell’amata viene sminuita da una tazza di polistirolo inosservata con il logo di un franchising che entra nell’inquadratura. I fotografi sono in realtà solo dei testardi scattatori. I grandi fotografi sono testardi e lucidi. Sono implacabili nel perseguire i loro intenti, ma allo stesso tempo aperti alle possibilità dei minimi detriti che una macchina fotografica è in grado di restituire. Sanno che, così come la fortuna è una questione di ottenere ciò che si vuole, la fortuna significa anche volere ciò che si ottiene. In qualsiasi momento i detriti possono diventare contenuti. Il meccanismo indica la strada. La mente adotta consapevolmente le possibilità della sua intenzione, permettendo all’intenzione di adattarsi, di ampliarsi. Lee Friedlander ha detto: “La fotografia è un mezzo generoso”.
In questo senso la fotografia è un teatro di empatia. L’ampiezza della sua precisione ottica nel rendere le informazioni visive permette, più che nella pittura – o nelle macchie d’inchiostro -, l’empatia tra le menti, ma anche per l’intero mondo dell’esperienza. Dal nucleo, al neonato, alla nebulosa, possiamo vedere e pensare a ciò che vediamo come a una consapevolezza comune e connessa. Al di fuori dei vincoli di un argomento ristretto, di una narrazione letteralista, di una posizione persuasiva o di un’inflessione di stile, le fotografie sono e devono essere fondamentalmente la scoperta, la definizione e la comunicazione dell’esperienza così come si verifica nella coscienza condivisa.







